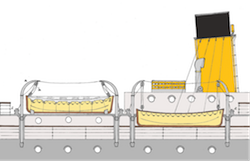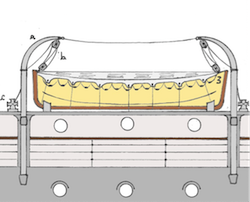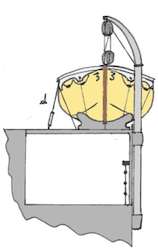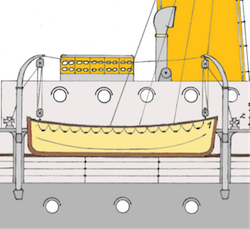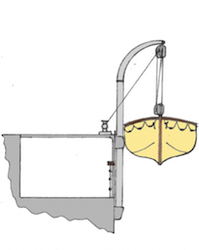La gruetta
radiale rappresenta, a differenza del bigo, il sistema
che più di tutti ha rappresentato lo “standard” per la
messa in mare delle lance tra l’ottocento ed i
primissimi del novecento. Esso è un sistema estremamente
semplice ed essenziale, sovente ad ammaraggio manuale
(in cui cioè le cime dei pescanti venivano rilasciate o
recuperate direttamente dai marinai), che tuttavia
consente di ottenere una certa affidabilità per lo scopo
a cui è preposto. Sistemi di questo tipo hanno
equipaggiato tutti i più grandi bastimenti durante l’era
Vittoriana fino al terminare dell’età Edoardiana nel
primo decennio del novecento, pur mantenendo qualche
posizione illustre su realizzazioni fino agli anni ’20.
Possiamo trovare questo sistema ad esempio sulla S.S.
Great Eastern del 1858, possente piroscafo “ibrido”
(cioè propulso dal vapore, pur conservando un’imponente
attrezzatura velica) progettato dal celebre ingegnere
britannico Isambard kingdom Brunel. Tale piroscafo,
dotato sia di propulsione con ruote a pale, sia di
propulsione ad elica e vele ausiliarie, fu il primo a
superare i 200 metri di lunghezza con scafo interamente
in ferro e rimase insuperato nella propria mole per
molti anni. Altre realizzazioni notabili sono
rappresentate dalla coppia di turbonavi RMS Mauretania
ed RMS Lusitania, nonché la RMS Aquitania della
compagnia britannica Cunard Line; quest’ultima, purché
le tali sistemi nel 1913 - anno del varo - fossero già
stati superati dal nuovo tipo “a quadrante”, venne
comunque equipaggiata con le gru radiali.
|
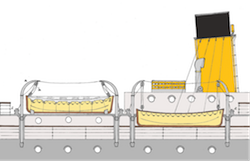
|